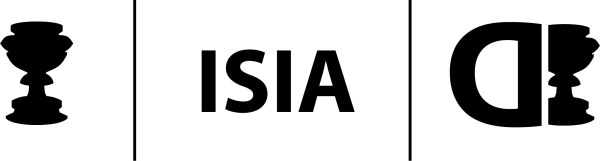La capa di Harvard salvata in nome della libertà di espressione (che le università Usa ostacolano)
Federico Rampini | 12 dicembre 2023 – Corriere (Link – Permalink)
La libertà di espressione ha fatto paurosi balzi indietro, la censura delle voci scomode è una pratica abituale. Nelle grandi università americane domina un pensiero unico allineato con l’estrema sinistra
La roccaforte di Harvard resiste, la bandiera palestinese sventolerà ancora a lungo nell’università più elitaria del mondo, dove le rette superano i 70.000 dollari annui. Dopo le dimissioni della presidente della University of Pennsylvania (U-Penn), Liz Magill, per ora non ci sarà un bis. Si è salvata da una sorte analoga la sua collega che dirige Harvard, Claudine Gay.
I difensori della Gay celebrano una «vittoria per la libertà di espressione sotto assedio da parte di ricchi donatori». È uno spettacolare rovesciamento di fronte, la dimostrazione che i rapporti di forze sono ancora quelli di sempre: le università di élite in America non stanno per vivere una decapitazione sistematica dei loro vertici. Le autorità accademiche accusate di aver tollerato atti di anti-semitismo e perfino violenze contro studenti ebrei, sono state abili a presentarsi come martiri della libertà di espressione, a descriversi nel ruolo di vittime, ingiustamente attaccate per aver difeso un principio sacro e inviolabile della Costituzione americana, il Primo Emendamento.
La polemica contro i vertici degli atenei di élite ha raggiunto una visibilità nazionale e perfino mondiale quando tre di loro sono state interrogate alla Camera di Washington. L’accusa è la stessa per tutt’e tre: aver tollerato un’ondata di antisemitismo dal 7 ottobre in poi, con un crescendo di violenze verbali e anche aggressioni fisichecontro gli studenti ebrei, da parte di giovani filo-palestinesi spesso apertamente solidali con i “metodi” di Hamas.
Chiamata a spiegare se considera legittimo invocare il genocidio degli ebrei come fanno quegli studenti, la presidente di U-Penn aveva detto: «Dipende dal contesto». Le sue colleghe di Harvard e dell’MIT non se la sono cavata meglio. Ma solo Liz Magill ha perso il posto. La Gay di Harvard è stata riconfermata, ha goduto della solidarietà del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Nei complessi equilibri della società americana e nei suoi innumerevoli tabù etnici, può aver pesato il fatto che Claudine Gay è una donna Black. Una sua eventuale rimozione sarebbe stata il pretesto per rilanciare il peggiore degli stereotipi antisemiti: una congiura di ricchi donatori ebrei ai danni di un’afroamericana, un evento potenzialmente esplosivo vista la tradizione antisemita della comunità Black, soprattutto nelle sue componenti islamiche e di estrema sinistra.
La campagna in difesa di Claudine Gay è stata condotta in nome della libertà di espressione, che le avrebbe precluso di censurare gli slogan pro-Hamas e in favore del genocidio degli ebrei. La controffensiva della presidente di Harvard e dei suoi sostenitori ha saputo diffondere nei media una narrazione efficace: gli appelli per la rimozione dei vertici accademici sarebbero opera di ricchi mecenati per lo più legati alla comunità ebraica. In buona parte fondato, questo argomento tocca corde sensibili nella popolazione studentesca che anima i cortei pro-Hamas: evoca il potere del denaro scatenato per imbavagliare i filo-palestinesi. Dietro questo genere di narrazionesi riaffacciano proprio i peggiori stereotipi anti-semiti. Anche chi in apparenza li respinge cerca di giustificare gli eccessi accaduti nei campus, per esempio il New York Times in prima pagina traccia una distinzione tra anti-semitismo e anti-sionismo: quest’ultimo sarebbe legittimo anche quando si propone la distruzione totale dello Stato d’Israele.
Da molti resoconti sui media si può avere l’impressione che questo scontro sulla libertà di espressione nel mondo universitario sia recente e legato al conflitto in Medio Oriente: una battaglia valoriale scoppiata appunto su temi come l’anti-semitismo o l’anti-sionismo, i diritti dei palestinesi. L’intervento di grandi mecenati che hanno minacciato di tagliare le loro donazioni alle superfacoltà di élite, ha fatto scattare contro di loro l’accusa di voler censurare il corpo docente e studentesco. Si è evocata perfino una nuova «caccia alle streghe», con riferimento ai processi pubblici del maccartismo negli anni Cinquanta, contro i comunisti o presunti tali.
In realtà la libertà di espressione ha fatto paurosi balzi indietro nei campus universitari americani, ma non dal 7 ottobre di quest’anno. La censura delle voci scomode nel mondo accademico è diventata abituale da molti anni, senza che nessuno invocasse il Primo Emendamento. A riprova, si può partire da un incidente vecchio ormai di un decennio.
Era il maggio 2014. Christine Lagarde – oggi presidente della Banca centrale europea, allora direttrice generale del Fondo monetario internazionale – era stata invitata a chiudere l’anno accademico dello Smith College, una università di prestigio, per sole ragazze, a Northampton nel Massachusetts. All’ultimo momento dovette rinunciare a tenere la sua conferenza alle neolaureate. La ragione: un gruppo di studentesse militanti l’aveva accusata di «complicità nei sistemi imperialisti e patriarcali», per via dei finanziamenti del Fmi in alcune zone del mondo.
Già allora, l’evento non fece scalpore. Da anni nei migliori atenei d’America, luoghi dove l’insegnamento costa cifre stratosferiche e solo minuscole percentuali dei candidati riescono a conquistare l’iscrizione, si celebra questo speciale rito accademico: la censura da parte degli attivisti. Eppure a pensarci bene l’evento non fu banale, per tante ragioni. Accusare il Fondo monetario di essere il braccio finanziario dell’imperialismo americano fa parte dell’armamentario marxista.
Tra i guru che oggi indottrinano i giovani americani una figura di rilievo è Ibram X. Kendi, celebre per lo slogan «il capitalismo è intrinsecamente razzista, il razzismo è essenzialmente capitalista». (Kendi non si è mai occupato del razzismo di cui è impregnato il regime comunista cinese). È un linguaggio che era già di moda negli anni Cinquanta del secolo scorso. Poteva avere un senso, allora, applicare quelle analisi stereotipate alle grandi organizzazioni multilaterali fondate dagli Stati Uniti subito dopo la seconda guerra mondiale. Da anni però il Fmi ha avuto una sterzata a sinistra: accadde grazie all’impulso di un molestatore sessuale socialista, il francese Dominique Strauss Kahn (ebbene sì, il mondo è complicato).
I prestiti del Fmi sono spesso linfa vitale per i paesi poveri; non hanno condizioni stringenti; rispettano l’impatto ambientale e perseguono obiettivi di giustizia sociale; spesso in sintonia con la Banca Mondiale promuovono l’emancipazione femminile. Il patriarcato semmai è parte integrante di quelle società arcaiche, dove le donne aspirano ai valori dell’Occidente. L’alternativa al Fmi sono i prestiti che la Cina eroga ai paesi emergenti per i suoi progetti delle nuove Vie della Seta: di regola sono opachi, hanno un impatto ambientale distruttivo, e nessun riguardo per i diritti umani.
Infine, cancellarela conferenza di Christine Lagarde ha privato le neolaureate dello Smith College di una testimonianza preziosa, una donna leader, una personalità che si è fatta strada in un mondo di maschi, che incarna valori concreti del femminismo nella competizione professionale. Com’è possibile che un pugno di giovani estremiste, ignoranti di realtà globale e indottrinate da un’obsoleta ideologia vetero-marxista, dettino legge in una università di élite? Non solo è possibile: è la regola nell’America di oggi.
Fire disinvitation database, è una banca dati specializzata che registra tutti i casi in cui una conferenza universitaria è stata cancellata perché l’oratore è stato dichiarato “persona non grata” dalle autorità accademiche. Il grafico che registra l’andamento di questi “dis-inviti” mostra un vistoso crescendo negli ultimi anni. Decine di conferenze, lectio magistralis, dibattiti e confronti pubblici, sono ormai disdetti ogni anno perché il relatore o la relatrice principale è finito su una lista nera: per aver detto in passato qualcosa che è stato giudicato offensivo. Giudicato offensivo… da chi? La stragrande maggioranza degli speaker si è visto negare l’accesso al campus universitario dopo che gruppi militanti dell’estrema sinistra hanno lanciato campagne contro di loro. Rettori e presidi si piegano, intimiditi, revocano gli inviti anche all’ultimo momento pur di evitare il peggio: contestazioni, proteste, boicottaggi che possono degenerare nella violenza.
L’estrema destra, che vent’anni fa tentava di replicare queste iniziative, ogni tanto ci prova ancora, ma è ormai ridotta a un ruolo marginale. Un pensiero unico domina nelle grandi università americane, detta legge negli atenei più prestigiosi come Harvard e Yale, Princeton e Berkeley, ed è allineato sull’estrema sinistra. A decidere chi ha diritto di parola e chi no, sono frange radicali dell’antirazzismo di Black Lives Matter, del femminismo di #MeToo. Sono i militanti transgender che impongono un uso politically correct dei pronomi: guai se i docenti osano rivolgere delle email usando il maschile o il femminile, solo il neutro plurale è ammesso, perché bisogna rispettare le identità “fluide”.
È diventato un obbligo rivolgersi agli ispanici non più come “latinos” o “latinas”, per non ingabbiarli in una rigida identità sessuale. Vanno chiamati Latinx o meglio ancora Latinx+. Gli ultrà delle minoranze hanno deciso che solo questa denominazione è «inclusiva» ed esprime il dovuto rispetto per tutte le identità di genere: bisessuali, trans, o in transizione e alla ricerca del proprio genere.
Dagli articoli del New York Times fino a Google, tutto il mondo politically correct si è adeguato alla nuova pulizia del linguaggio. Eppure un sondaggio apparso su The Economist rivela che solo il 4% della popolazione ispanico-americana predilige il nuovo Latinx. È una storia familiare: le avanguardie militanti dicono di difendere un popolo che non si sente affatto rappresentato da loro. Nella vasta comunità degli ispano-americani che abitano negli Stati Uniti sono numerosi i cattolici e ancor più i protestanti evangelici, assai conservatori sui temi etici e legati a una visione tradizionale della famiglia. Non importa: nei college comanda la polizia della parola, guai a chi sfida le direttive di questa avanguardia rivoluzionaria.
Il settimanale The Economist (in “The threat from the illiberal left”, 4 settembre 2021) oltre due anni fa metteva in luce un paradosso, un’asimmetria nella nostra percezione degli attacchi contro le libertà e i diritti. La minaccia contro la democrazia liberale che viene dalla destra trumpiana è evidente nella sua brutalità. Quella destra populista «denigra la scienza e lo Stato di diritto, subordina i fatti e la ragione alle emozioni tribali». È ben rappresentata, anche se non da sola, nell’area dei no-vax e nel negazionismo climatico. Inoltre il mondo intero ha potuto vedere in telecronaca diretta le violenze eversive dell’estrema destra durante l’assalto al Congresso di Washington il 6 gennaio 2021. Ma c’è un attacco insidioso e sottile contro la democrazia americana che viene dalla «sinistra illiberale». È questo l’attacco oggi di gran lunga più potente, perché la sua influenza culturale è maggiore e si estende alle istituzioni centrali della società americana.
Dopo avere affermato la sua egemonia nelle università di élite, una generazione di giovani laureati formati dalla sinistra illiberale ha assunto posizioni di comando nei giornali e nelle tv, nelle grandi aziende digitali che gestiscono i social media, l’intelligenza artificiale e i motori di ricerca. Le nuove generazioni di insegnanti dei licei e delle scuole medie – soprattutto se pubbliche – sono ideologicamente vicine alla sinistra illiberale, e i manuali di studio che adottano ne riflettono la visione. Nel mondo delle aziende, in particolare Big Tech e tutte le multinazionali il cui marketing si rivolge ai giovani, il management e i consigli d’amministrazione sono stati invasi dalle nuove generazioni formate nei college politically correct dove detta legge la sinistra illiberale.
Il loro credo fondamentale è questo: poiché gli Stati Uniti dalla loro fondazione sono una società intrinsecamente sessista, razzista, xenofoba, oggi non si può perseguire una «parità dei diritti» perché sarebbe fasulla; bisogna invece ridurre i diritti dell’America privilegiata e oppressiva (i bianchi) per riparare le ingiustizie. Togliere il diritto di parola a chi non difende attivamente le minoranze è sacrosanto. Si instaura una piramide di caste rovesciata, in cui gli ex-ultimi devono essere sistematicamente i primi. Diversità, Equità, Inclusione sono i principi con cui si nobilitano le nuove discriminazioni. Il vittimismo diventa il criterio ispiratore della vita sociale. Chiunque dissente è una minaccia per i diritti degli oppressi, va zittito, neutralizzato.
Il salvataggio di Claudine Gay dice che per adesso prevale questa «interpretazione» del Primo Emendamento, che da molti anni legittima ogni censura e ogni voce fuori dal coro, applicando le regole della potente burocrazia abilitata a imporre i principi della Diversity, Equity, Inclusion.